"L'arte di operare con dei concetti non è innata e neppure acquisita con la coscienza comune di tutti i giorni, ma richiede invece un pensiero reale e questo pensiero ha una lunga storia sperimentale, né più né meno dell'indagine naturalistica sperimentale. Appunto imparando a far propri i risultati dello sviluppo della filosofia durante venticinque secoli, essa si libererà da un lato da ogni filosofia della natura che stia a parte e al di fuori e al di sopra di essa, ma anche, d'altro lato, dal suo proprio metodo limitato di pensare, ereditato dall'empirismo inglese" (F. Engels, seconda prefazione all' Anti-Dühring).
L'origine della nuova teoria della conoscenza fondata sulla dialettica caso-necessità
Pietro De Michelis
studieriflessioni
Vicende personali imprevedibili e contingenti orientarono l'interesse dell'autore di questo blog nella direzione del rapporto caso-necessità fin dal 1983, ma inizialmente senza risultati degni di nota. Anche l'approfondimento della "Dialettica della natura", nella quale Engels aveva posto il problema del rovesciamento del caso nella necessità, se era riuscito a indicare una strada, non mostrava però né l'ingresso né alcuna via d'uscita. Finché, in una calda giornata estiva del 1985, un'improvvisa intuizione: i singoli elementi di un complesso vanno posti nella sfera del caso, mentre i complessiappartengono alla sfera della necessità. In sostanza, i singoli elementi di un complesso, in quanto tali, sono sempre soggetti al caso, caso che si rovescia nel suo opposto dialettico: la necessità del complesso stesso.
L'intuizione fu il risultato di un confronto tra due esempi empirici: il traffico su strada dell'epoca contemporanea (suggerito dall'esodo estivo) e le battaglie della prima guerra mondiale (suggerite da letture storiche di quel periodo). Nel primo esempio, il singolo incidente mortale può essere concepito come effettivamente casuale, mentre se consideriamo il complesso del traffico automobilistico, troviamo frequenze statistiche effettivamente necessarie, perché rendono conto della regolarità e della costanza degli incidenti mortali nel loro insieme.
Nel secondo esempio, le lunghe battaglie della durata di mesi evidenziavano una statistica di elevata mortalità complessiva, all'incirca di frequenza 1/2. Quindi la cieca necessità era facilmente riconoscibile come statistica complessiva, sebbene il singolo fante fosse abbandonato ai capricci del caso secondo la probabilità 1/2. Insomma, la probabilità in se stessa non garantisce nulla all'individuo, e la sorte del singolo rimane imprevedibile, mentre la frequenza stabilisce la certezza del risultato. Nel nostro esempio, facile stabilire che su un milione di fanti, cinquecentomila sarebbero morti, ma impossibile stabilire a chi sarebbe toccato morire.
A questa prima intuizione che collegava il caso con il singolo e con la probabilità, e la necessità con il complesso e la frequenza, ne seguì un'altra: i grandi numeri delle singole possibilità casuali si rovesciano nella realtà necessaria che rappresenta l'oggetto complessivo, l'unico accessibile alla reale conoscenza. Ne derivarono come conseguenza due serie di concetti tra loro omogenei: la prima serie appartenente alla sfera del caso, la seconda appartenente alla sfera della necessità:
I) caso, singolo, probabilità, possibilità
II) necessità, complesso, frequenza, realtà.
Ecco dunque come il caso si rovescia in necessità: può farlo perché esistono altre polarità dialettiche che, per così dire, glielo permettono. Allora è il caso relativo ai numerosi singoli elementi, soggetti alla probabilità, che si rovescia nella necessità del complesso, soggetto alla frequenza statistica. E in tal senso possiamo essere certi del passaggio dalla possibilità alla realtà. Questa, in sostanza, fu l'intuizione di una calda giornata d'estate, intuizione che avrebbe potuto essere messa alla prova, in tempi relativamente brevi, in economia e soprattutto nella storia politica e militare, discipline nelle quali l'autore aveva una certa dimestichezza.
Ma un'ultima intuizione, quella di trovarsi di fronte a una difficile questione di teoria della conoscenza, appartenente alla storia del pensiero umano, per qualche motivo trascurata, messa da parte e perciò mai risolta, suggerì di prendere un'altra strada molto più lunga e faticosa: cercare nella teoria della conoscenza, a partire dall'antico pensiero greco, se e in quale misura la questione del rapporto caso-necessità si fosse presentata e quali risposte avesse avute, se le avesse avute. Un'analoga ricerca era inoltre necessaria nelle scienze naturali, almeno a partire da Galileo per la fisica e da Darwin per la biologia.
Limitandoci sobriamente ai fatti: otto furono gli anni (1985-1992) necessari per porre le basi di un progetto di approfondimento decennale (1993-2002) che terminò con la stesura di tre volumi (teoria della conoscenza, fisica, biologia). Nel primo periodo, l'autore pazientemente studiò per apprendere i linguaggi specifici, gli argomenti e le difficili questioni (ma anche le più diverse banalità e assurdità) della storia della filosofia e delle scienze naturali. Poi, con uno sforzo raddoppiato, dopo altri quattro anni di studio, nel 1996, erano già pronte le tesi generali che riassumevano la logica dialettica caso-necessità, sviluppata nella teoria della conoscenza riguardo alla evoluzione della materia nel cosmo e alla evoluzione della vita terrestre, fino all'origine dell'uomo e della coscienza.
Queste tesi servirono sia a fare il punto dei risultati raggiunti, sia per tracciare gli ulteriori approfondimenti per i sei anni successivi (1997-2002), anni in cui molte sono state le difficili questioni risolte e molti i punti fermi stabiliti nei tre volumi, dai quali è tratta una parte degli scritti di questo blog.
Poiché gli approfondimenti successivi non hanno scalfito le considerazioni generali esposte nelle tesi del 1996, le quali perciò restano tuttora valide, l'autore ritiene sia giunto il momento di pubblicarle nel suo blog: blog che ha già fatto la sua parte con decine di scritti che permettono di farsi un'idea sull'importanza della nuova teoria della conoscenza fondata sulla dialettica caso-necessità.
Tesi di teoria della conoscenza sulla evoluzione della materia
I] Punto di partenza della teoria della conoscenza: la determinazione del reale rapporto caso-necessità. I processi e i fenomeni della natura appaiono a prima vista un groviglio inestricabile di caso e necessità. Il pensiero umano può districare questo apparente groviglio naturale mediante il pensiero dialettico: i concetti di caso e necessità vanno perciò concepiti come opposti polari che si manifestano l'uno mediante l'altro (determinazione reciproca e rovesciamento nell'opposto).
II] Come si esprime la dialettica caso-necessità in natura, e come può essere riflessa nel pensiero? Ogni forma materiale inorganica e organica può sorgere soltanto in un processo di sviluppo, nel quale essa rappresenta un dato stadio o momento. Il raggiungimento di questo momento non è altro che il risultato da nessuno voluto del rapporto polare tra il caso relativo ai singoli numerosi oggetti o eventi e la necessità relativa al complesso specifico di questi numerosi oggetti o eventi. La casualità dei numerosi elementi che partecipano a un fenomeno o a un processo naturale si rovescia nella necessità del risultato complessivo, sia esso un atomo, una molecola, un corpo, ecc.; sia esso una cellula, un tessuto, un organismo, ecc.
III] Ciò che a un dato livello è solo uno dei numerosi elementi di un complesso, a un livello inferiore è, a sua volta, un complesso di numerosi elementi. E viceversa: ciò che a un dato livello è un complesso di numerosi elementi, al livello superiore è solo uno dei numerosi elementi di un complesso. Il tutto, quindi, si risolve in una serie di contenitori di contenitori, ovvero di contenitori a loro volta contenuti.
IV] Il riflesso scientifico dell'oggettiva dialettica naturale caso-necessità è dato dal rapporto dialettico probabilità-statistica. Il calcolo delle probabilità ha per oggetto l'ampiezza della casualità relativa ai numerosi singoli elementi di un dato complesso; e la statistica, intesa come necessità relativa al complesso, va considerata non solo nelle sue frequenze medie, ma soprattutto nelle sue frequenze eccezionali, in quanto le rarità, le eccezioni statistiche hanno un'importanza fondamentale nella evoluzione della materia.
V] L'idea di fondo che attribuisce al rapporto dialettico probabilità-statistica il significato di strumento d'indagine principale, per la riflessione dei fenomeni e processi naturali, è la seguente: in natura si tratta di oggetti o eventi molto numerosi e, singolarmente presi, affatto casuali, il cui complesso di appartenenza appare qualitativamente differente, ossia appare come necessità del risultato relativamente costante e duraturo, soltanto però in senso statistico, e principalmente in forma di rarità statistica. Per spiegarci con un esempio: il linfocita B è una cellula e, come tale, nasce, si nutre, si riproduce e muore, seguendo un suo ciclo di sviluppo soggetto al caso; ma 10^12 linfociti B nel loro casuale movimento entro l'organismo umano e nella loro casuale diversa individualità, si rovesciano complessivamente nella necessità cieca e da nessuno voluta o predeterminata della risposta immunitaria. Così, osserviamo sperimentalmente che è l'eccezione statistica (un linfocita su circa un milione) che ogni volta garantisce la difesa immunitaria dell'organismo. I grandi numeri di linfociti rappresentano perciò soltanto il serbatoio casuale della necessità statistica, che si manifesta come eccezione, come rarità.
VI] Questa regola vale in generale, sia per la materia organica che per la materia inorganica. Il rapporto dialettico caso-necessità, che il rapporto dialettico probabilità-statistica riflette, mostra la seguente fondamentale peculiarità della natura: che, sulla base dei grandi numeri casuali, la rarità o eccezione - sorta casualmente dal serbatoio dei grandi numeri - si rovescia in necessità, sia che si manifesti nella formazione degli elementi e dei corpi della fisica sia che si manifesti nella formazione delle cellule e degli organismi della biologia.
VII] Tutto ciò richiede e presuppone un enorme dispendio. Il dispendio rappresenta il principale contrassegno della natura, il prodotto più grandioso del movimento della materia: prima ancora di produrre il protone e l'elettrone, il movimento caotico della materia primordiale produce un enorme dispendio di energia (termica). Il dispendio è la condizione basilare, la circostanza principale della evoluzione delle forme materiali, che rappresentano, viceversa, delle rarità, delle eccezioni.
Definiamo perciò legge del dispendio e dell'eccezione statistica la cieca necessità prodotta dal caso, tipica di ogni prodotto naturale. Sulla base di un grande dispendio, sorgono per necessità statistica rarità, eccezioni che rappresentano i prodotti complessivi dell'evoluzione. L'evoluzione è dunque cieca in tutte le direzioni, ma tutte le direzioni nei tempi lunghi dell'evoluzione si riducono a poche direzioni eccezionali, fondamentali.
VIII] Se ogni processo della natura segue la legge del dispendio, lo farà però in un suo modo specifico, che dipende dall'ampiezza della casualità relativa ai singoli numerosi elementi del complesso fondamentale del processo stesso, che evolve mutando fino al suo termine naturale. La scienza può giungere alla reale conoscenza dei processi, ovvero alla conoscenza della dialettica caso-necessità dei processi, solo quando è in grado di determinare il rapporto probabilità-statistica, ossia quando questo rapporto è alla sua portata. E ciò dipende soltanto dallo sviluppo della scienza stessa. Così, ad esempio, è solo in tempi molto recenti che si è potuto determinare il rapporto probabilità-statistica in relazione al sistema immunitario (anche se gli immunologi continuano ancora a fraintendere).
Applicazione e sviluppo delle tesi nella evoluzione della materia inorganica
1] Se consideriamo la materia inorganica, oggetto della Fisica, vediamo immediatamente espressa nel secondo principio della termodinamica la legge del dispendio e della eccezione statistica. Il dispendio, qui, si manifesta fondamentalmente come dissipazione di energia termica in calore; e questo è il risultato più evidente del cieco movimento della materia (energia), che determina l'evoluzione delle più diverse forme materiali. Queste forme, pur rappresentando delle rarità statistiche, sono quantitativamente ancora immense, perché quasi infinita è la quantità di materia-energia presente nel big bang.
2] Di conseguenza, la materia luminosa (le galassie di stelle) rappresenta una percentuale minima dell'energia originaria, la maggior parte della quale si è "dissipata", in senso termodinamico e dal punto di vista evolutivo. Di contro, troviamo che la maggior parte dell'energia originaria è degenerata in materia oscura, la quale conserva l'energia dissipata in forma di energia potenziale gravitazionale.
3] L'atomo d'idrogeno, il fondamento della materia luminosa evolutiva, è il prodotto statisticamente raro del raffreddamento della originaria materia calda: esso rappresenta la "massificazione" di una parte molto modesta della materia originaria, la maggior parte della quale si è addensata in materia oscura, perciò invisibile.
4] Si possono riassumere nei seguenti punti le conseguenze della legge del dispendio in fisica:
a) la dissipazione di energia, all'inizio molto elevata, e via via in misura minore;
b) la massificazione dell'energia (atomi, stelle, galassie) che rappresenta il risultato eccezionale dell'evoluzione inconsapevole della materia nei tempi lunghi: qui il dispendio è sempre molto grande ma non immenso come nei primordi;
c) l'espansione nel cosmo della materia luminosa, che avviene con un movimento rotatorio estremamente rapido, perché il big bang ha lasciato come residuo degenerato un nucleo di materia oscura, incommensurabile per dimensione, massa e momento angolare: di conseguenza i grandi oggetti del cosmo ruotano attorno a questo centro, e attorno al proprio centro, rispettivamente per attrazione gravitazionale e per impulso originario;
d] l'evoluzione per frantumazione dei giganteschi residui del big bang, a partire dalle grandi nubi di gas d'idrogeno e per finire con le attuali galassie, passando attraverso varie fasi: dei Quasar, delle Seyfert, ecc., che lasciano come risultato i superammassi, gli ammassi, ecc. ovvero sistemi autogravitanti (contenitori di contenitori) ai cui centri si trovano masse oscure addensate, attorno alle quali ruota la materia luminosa;
e] la forma specifica dell'universo come contenitore di contenitori, nei quali ogni oggetto ruota attorno a un centro: la terra attorno al Sole, il sistema solare attorno al centro della galassia (via Lattea), la galassia attorno al centro dell'ammasso, l'ammasso attorno al centro del superammasso, il superammasso attorno all'origine: il big bang (supponendo terminato il numero dei contenitorj);
f] la forma di materia degenerata, oscura, che costituisce il centro di ogni contenitore, e che possiede una enorme energia potenziale gravitazionale, forma di conservazione dell'energia dissipata principalmente nei collassi gravitazionali e secondariamente nella lenta espansione della materia luminosa nel cosmo.
5] Come conseguenza dei punti di cui sopra, il concetto termodinamico di entropia deve essere messo in relazione con l'energia potenziale gravitazionale: entrambe crescono a spese dell'energia attiva (cinetica, termica e termonucleare).
6] A riguardo dei cosiddetti costituenti ultimi, occorre cambiare impostazione: poiché la materia evolve con grande dispendio, producendo come eccezioni statistiche gli atomi e i corpi, in seguito a una lunga serie di decadimenti, dobbiamo considerare l'esistenza reale di date forme materiali in rapporto sia all'energia che esse racchiudono come massa sia all'energia termica presente nell'ambiente. Una cosa sarà di conseguenza lo stato della materia nel big bang, altra cosa lo stato della materia nelle nubi d'idrogeno, altra cosa ancora lo stato della materia nei nuclei delle galassie, ecc.; la difficoltà si risolve così: ciò che esiste, esiste a una data energia interna ed esterna, ossia in un ambiente a equilibrio termico.
7] Occorre quindi pensare come cose qualitativamente diverse tra loro i quark, i nucleoni, gli atomi, le molecole: nel senso che le molecole sono qualcosa di meno della somma di atomi, e questi sono ancora meno della somma di nucleoni, e questi ultimi sono incommensurabilmente meno della somma dei quark che dovrebbero contenere. Per conseguenza occorre respingere la concezione dei "costituenti".
8] La realtà è che il dispendio di energia necessario alla formazione dei complessi (nucleoni, atomi, molecole) sottrae ai cosiddetti costituenti una parte, e spesso la maggior parte, della loro originaria energia; così, ad esempio, i quark possiedono un'energia di gran lunga maggiore di quella dei nucleoni che dovrebbero contenerli, perciò essi non possono trovarsi entro i nucleoni tali e quali erano allo stato "libero" nel loro ambiente termico naturale: ciò che si troverà nei nucleoni può essere solo una minuzia dell'energia originaria. E chi registra questo fatto è il cosiddetto "difetto di massa", che più propriamente dovrebbe essere denominato "difetto di energia".
9] Ne consegue che, a livello delle particelle, i cosiddetti costituenti rappresentano uno stato della materia differente qualitativamente dalla loro forma libera, stato che non può essere conosciuto in alcun modo, per il semplice motivo che, nel tentativo di "vederlo", forniamo un quantitativo di energia che lo riporta al suo stato originario (eccezion fatta per i quark, finora). In generale, possiamo concludere che ogni forma della materia, dal momento in cui si combina in una forma superiore, in un complesso, tramonta in esso, per usare un'espressione di Hegel.
10] Allora non dovremmo stupirci che esista un limite nella evoluzione della materia inorganica, un limite dal quale nessuna forma materiale possa tornare a sussistere libera, se non a condizione di un apporto di energia talmente elevato che solo il collasso finale dell'intero universo può permettere: questo limite è la massima densità raggiungibile dalla materia: ossia la materia oscura, scambiata a torto per "buco nero", il cui difetto di massa mostra il tramonto definitivo dei protoni nell'attuale ciclo.
11] Per concludere, questo dispendio di energia, che si ritrova registrato nel "difetto di massa", è tanto maggiore quanto più si sale la scala delle energie, e probabilmente segue la legge dell'inverso del quadrato.
Applicazione e sviluppo delle tesi nella evoluzione della materia organica
Riguardo alla materia organica, oggetto della biologia, riassumiamo nei seguenti punti le manifestazioni della legge del dispendio e della eccezione stistica.
1] Il dispendio si manifesta principalmente nello sperpero degli organismi, sperpero che assume le più diverse forme e dimensioni a seconda della scala dell'evoluzione: tanto maggiore quanto più si va in basso, tanto minore quanto più si va in alto.
2] Anche con la materia organica occorre prima di tutto distinguere i complessi dai loro numerosi elementi singoli. Ogni complesso è a sua volta un singolo elemento di un complesso superiore e, viceversa, ogni elemento di un complesso è a sua volta un complesso inferiore: cosi, ad esempio, un nucleosoma è sia un elemento basilare di un genoma eucariotico, sia un complesso ben definito di copie di basi; così un organo è sia elemento di un organismo animale, sia un complesso di cellule, ecc.
3] L'importante è comprendere che ciò che a un dato livello è preso come complesso rappresenta la necessità statisticamente determinabile, e ciò che è preso solo come singolo elemento rappresenta il caso indeterminabile, probabilistico. Quando si passa a considerare un livello di complessità superiore o, viceversa, inferiore, cambia di conseguenza anche ciò che attiene alla necessità e al caso: ad esempio, se consideriamo il genoma di un singolo linfocita B, esso rappresenta la necessità, ma le sue manifestazioni in ogni singolo linfocita B sono solo capricci del caso; però, come il caso relativo alle singole basi si rovescia nella necessità del genoma di ogni singolo linfocita B (ognuno diverso dall'altro), così il caso relativo ai singoli genomi linfocitari tra loro diversi si rovescia nella necessaria risposta immunitaria.
4] Questo modo di vedere, questa impostazione teorica permette di comprendere la difficile questione, mai finora risolta, della selezione naturale in rapporto al grandioso fenomeno della estinzione dei complessi viventi: specie, generi, famiglie... ordini, ecc. La selezione riguarda, ad ogni livello di complessità, oggetti organici che sono qualitativamente differenti: c'è infatti la selezione degli organi più diversi, ma c'è anche la selezione degli organismi più diversi che hanno in dotazione questo o quell'organo fra i tanti, e c'è anche la selezione delle specie più diverse che raggruppano questi organismi d'ogni foggia, ecc. La selezione delle specie è dunque soltanto un aspetto di tutta la faccenda, anche se rilevante; e, comunque, se si parla di selezione delle specie, occorre aver chiaro che essa, per necessità, deve riguardare le specie medesime e non i loro singoli individui: per le specie, gli individui rappresentano soltanto la sfera della casualità.
5] Ma, accanto alla selezione che rappresenta un risultato raro ed eccezionale, c'è l'estinzione che rappresenta la cieca ed assoluta necessità, fondata sul caso, della evoluzione biologica. L'estinzione è la più lampante manifestazione della legge biologica del dispendio; la sua misura è nota ormai da diversi decenni, ma i biologi sono degli "orologiai ciechi": o non la vedono, o la negano pur vedendola, o la vedono ma ne minimizzano l'entità e la portata. L'estinzione compare a tutti i livelli; qui di seguito consideriamo i due livelli di base, i complessi-organismi e i complessi-specie:
a) la notevole estinzione degli organismi ad ogni generazione era già stata rilevata da Darwin che, però, la considerò come un dato di fatto relativo a embrioni e neonati, sul quale non indagare; questa estinzione è tanto maggiore quanto più si scende la scala della evoluzione e ci si avvicina ai primordi della vita: l'esempio più noto di vita effimera degli organismi è data dai procarioti;
b) l'estinzione delle specie come fenomeno grandioso è un'acquisizione più recente: oggi si calcola che per ogni specie attualmente vivente circa mille siano scomparse dalla faccia della Terra, e si tratta di specie animali evolute nel Cambriano; l'esempio più noto in tal senso è l'ordine dei Dinosauri, estintosi in tempi geologici relativamente recenti.
6] Che cosa è dunque la selezione delle specie? E' una necessità cieca che deriva dalla casualità dei singoli organismi beneficiati dalle circostanze, sopravvissuti all'estinzione, che per moltiplicazione diventano dominanti protempore; allo stesso modo, se consideriamo i vari complessi superiori, i generi, le famiglie...gli ordini...infine i regni, la necessità della evoluzione è garantita solo statisticamente, sulla base della grande estinzione del maggior numero di specie comparse sulla terra: la selezione è dunque la necessità del prodotto biologico raro, eccezionale, l'eccezione statistica di un grande dispendio.
7] Perciò, la specie più evoluta in assoluto, l'uomo, altro non è che una rarità statistica (il più raro dei prodotti biologici) che, sebbene casuale nella sua insorgenza proprio in un dato pianeta e in dato periodo, doveva necessariamente uscire fuori prima o poi per la legge del dispendio e dell'eccezione statistica.
In conclusione
La legge del dispendio, con il suo corollario: l'eccezione statistica, non soltanto guida il reale movimento della materia inorganica e organica, ma permette di stabilire una volta per tutte che l'evoluzione della materia è ciecamente necessaria, non predeterminata, da nessuno voluta, e non determinabile mediante leggi di causalità diretta, secondo le vecchie modalità del determinismo ora riduzionistico ora olistico. L'evoluzione della materia può essere intesa come l'incessante lavoro prodotto dall'automovimento della materia stessa, che produce principalmente dissipazione (spreco) del proprio movimento, grazie al quale sorgono forme materiali inorganiche e organiche che continuamente si modificano.
Se la natura lavora in maniera incommensurabilmente dispendiosa, i suoi risultati più duraturi non possono essere realizzati per assoluta necessità, ma per una necessità relativa, la cui ragione è il caso stesso: il punto di partenza è sempre il caso relativo ai grandi, quasi infiniti, numeri di elementi materiali in gioco che nessuno e niente può organizzare e ordinare per uno scopo predeterminato. Così appare (all'uomo) un groviglio casuale; ma questo groviglio della natura manifesta il suo ordine e la sua necessità relativi nei fenomeni e processi complessivi che rappresentano le varie tappe dell'evoluzione. Questo ordine e questa necessità relativi diventano comprensibili mediante leggi statistiche e la riflessione dialettica.
E così l'uomo cosciente, il prodotto più elevato della natura, è saltato fuori dalla evoluzione con quella necessità statistica che ha per fondamento la casualità dei grandi numeri in gioco: senza una materia-energia praticamente infinita, senza uno sterminato universo ciclico, senza miliardi di miliardi di stelle con relativi pianeti, senza i pressoché infiniti atomi, senza il grandioso numero di molecole organiche sul pianeta Terra, senza le centinaia di milioni di diverse specie che si sono succedute in questo pianeta, insomma senza questo enorme apparato, l'uomo, come risultato dell'evoluzione spontanea, inconsapevole e cieca della materia, sarebbe inconcepibile.
Rimarrebbe soltanto la spiegazione della creazione volontaria e cosciente. Insomma, non ci possono essere vie di mezzo: o tutto si spiega con la dialettica caso-necessità che rende ragione del grande dispendio o tutto deve essere ricondotto alla creazione divina; ma, in questo caso, come spiegare il dispendio?

(NV+2010).jpg)

+copia.jpg)


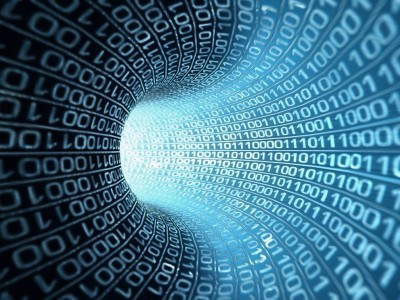

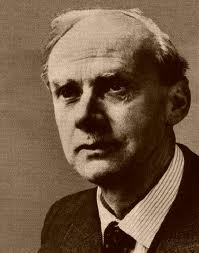



(NV+2010).jpg)






